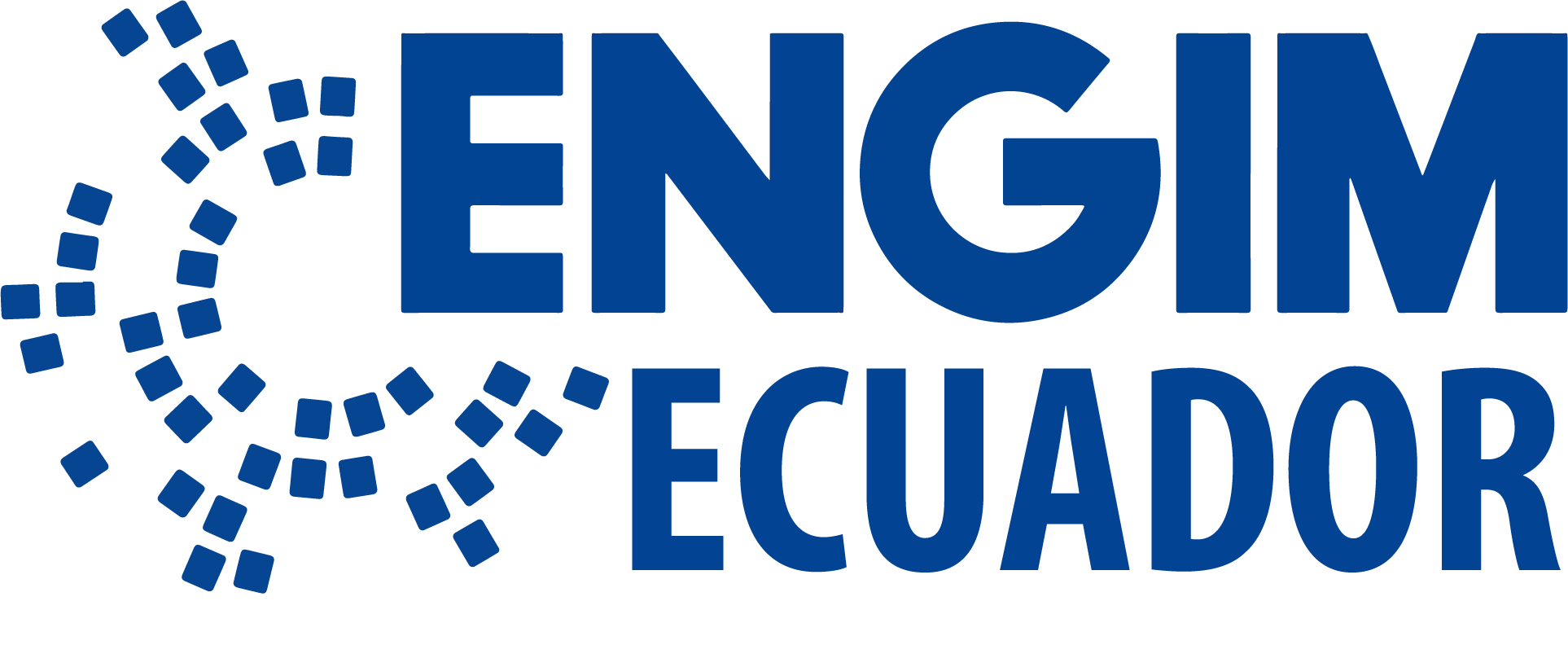di Ilaria Bonavita – Il pensiero popolare vede la foresta pluviale come un luogo inospitale, una giungla colma di pericoli che la rendono inadatta alla minima interferenza e presenza umana; eppure, è difficile dissociare a questa immagine stereotipata quei suoni armoniosi che simboleggiano una presenza di vita rigogliosa. Come può un’idea brulicante di vita accostarsi a un’idea di luogo così ostico?
Mi trovo a Tena ormai da sei mesi, una cittadina situata nell’Oriente ecuadoriano, quell’area geografica localizzata a est della cordigliera andina e dominata dal bacino del Rio delle Amazzoni.
Ebbene sì, questo contrastato ma meraviglioso mondo è ormai entrato a far parte della mia vita, con i suoi crepuscoli mattutini, di nebbiolina sospesa verso l’orizzonte alberato, che scandiscono la mia sveglia e la sua aria densa di umidità che mi ricorda di essere qui, in Amazzonia.
«Sto veramente camminando tra queste distese verdi tropicali con l’intenzione di monitorare quelle giovani piantine immerse nella foresta disboscata?» È un pensiero che va e viene, mentre il mio corpo e la mia mente elaborano adattamenti a questa nuova realtà quotidiana.
È difficile realizzare di essere qui, quando ti ritrovi inghiottita da labirinti di alberi che sovrastano ogni altra visuale… e da un passo spedito, scandito dalle abitudini kichwas che spezzano il mio fiato, incapace di adattarsi a questo clima tropicale, dove il sudore frammisto all’umidità ti avvolge in un modo così perpetuo.
Anche lo stomaco ha difficoltà a decifrare questi nuovi stimoli – culinari – tra spiedini di chontakuro (Rhynchophorus palmarum, larve di coleotteri affumicate) assaggi di formiche crude o tostate (Myrmelachista schumanni dal sapore piacevolmente citrico, o Atta laevigata, conosciuta come “ukuy” che ricorda un lontano pop-corn) o spadellate di garabato yuyu (Macrothelypteris torresiana), palmito e semi di patas muyu (germogli di felci e tenere foglie di palma – Bactris gasipae – detta chonta; patas muyu, nome kichwa del comune Cacao blanco, Theobroma bicolor) per non parlare delle mille sfumature di sapori aciduli che contraddistinguono buona parte della frutta amazzonica; del pane non rimane che un lontano ricordo, sostituito con varianti di platano e yuca, onnipresenti in qualunque pasto della giornata.
Questi nuovi sapori assumono lentamente una certa familiarità… e dopo sei mesi anche le porzioni e i ritmi a cui eri abituata vanno a rimodularsi, ritrovandoti a ingurgitare bicchieri stracolmi di chicha (tipica bevanda ricavata dalla fermentazione di un ingrediente che varia tra yuca, platano e mais) con una rapidità che nemmeno una sete prolungata era mai riuscita a velocizzarti a tal punto. Questa bevanda sembra scandire la quotidianità, un po’ come farebbe il caffè nelle nostre frenetiche abitudini occidentali; le uniche cose frenetiche che percepisco in questo posto sono la rapidità nel bere mestoli di chicha e nel muoversi con quel passo felpato, ovattato dal pantano che solo una persona autoctona è in grado di oltrepassare con un tal senso di sicurezza e di indifferenza. Non è tanto la velocità a stupirmi, quanto l’inevitabile trascuranza che ne deriva, nell’osservare la natura circostante, per seguire quel passo svelto e costante che mai un naturalista riuscirebbe ad avere di fronte a questa diversità biologica che pulsa tutto attorno.
In realtà, da un’osservazione paesaggistica blanda, osservando quel che riesco durante le attività in campo, ho notato sin da subito quell’alternarsi costante di una serie di specie pioniere, come se fossero messe lì a ricordarti che stai vivendo a contatto con la parte deforestata dell’Amazzonia, dove il disboscamento illegale o negligente è così tangibile ed evidente di fronte a tali scenari di tabula rasa. Persino a uno sguardo fugace dal finestrino, il paesaggio appare dominato da distese di specie ornamentali, aliene e pioniere che sfrecciano svettanti lungo il bordo strada e si ripresentano puntualmente in ogni campo – finca – da monitorare: balsa (Ochroma pyramidale), guarumo (Cecropia obtusifolia), specie erbacee del genere Heliconia, Calathea e Fittonia, o arbusti violacei come Cordyline spp e Codiaeum spp, spesso usati come indicatori di confine di terreni privati… o ancora epifite del genere Philodendron, col tipico accrescimento che manifestano in presenza di un bosco secondario.

«Mañana geotag», credo sia la frase più pronunciata di tutti questi mesi tra noi dell’equipo vivero, due semplici parole pronunciate con un tono velato, di avvertimento, come a volersi preparare psicologicamente per l’imprevedibilità che contraddistingue ogni uscita in campo; «el gps?» è diventato un surrogato del buongiorno, seguito dall’elenco degli strumenti necessari da portare in finca per realizzare le attività di monitoraggio e georeferenziazione (geotag). Insomma, la mattina sembra iniziare con un sussurro di poche parole chiavi, lo stretto indispensabile per non disattivare quella modalità automatica di risparmio energetico guidata dalla consapevolezza dello sforzo fisico che ci aspetterà. L’immancabile musica kichwa e il reggaeton mattutino che dominano nelle frequenze radio accelerano la fase di risveglio, fino all’arrivo al punto d’incontro con i beneficiari, proprietari dei terreni da riforestare o delle cosiddette chakras – sistemi agroforestali che garantiscono il sostentamento alimentare familiare – ai quali si cedono in donazione piante fruttali e forestali a seconda delle necessità. Quando rispettano l’orario dell’appuntamento, ci si ritrova sull’uscio di casa o nei pressi del loro terreno, rigorosamente muniti di machete, indispensabile per lasciare spazio a percorsi apparentemente immaginari che conducono verso la finca. A volte dei beneficiari non c’è alcuna traccia, le piante consegnate sono ancora lì, nell’attesa di una messa a dimora definitiva che sarebbe dovuta avvenire entro due settimane dalla consegna; nel peggiore dei casi ci troviamo di fronte a una mappa stilizzata della finca con indicazioni alquanto discutibili sull’ubicazione delle piante da monitorare. Qualunque sia il possibile scenario, rimane la paura inconscia di trovarsi di fronte a campi devastati dall’assenza di ombra, segni di un disboscamento incontrollato frutto di un’inadeguata gestione del proprio terreno, in quanto è ancora d’uso comune ritenere che le foreste siano impossibili da coltivare in assenza di totale deforestazione.

Camminando tra una finca e l’altra, questi pensieri diventano un rumore di sottofondo, sovrastati da stimoli di ogni tipo provenienti dall’ambiente circostante: gli urli delle scimmie leonine o chichico rojo (Leontocebus lagonotus) che interrompono bruscamente il silenzio del cammino o la vista di animali selvatici addomesticati, come l’aguti o guatusa (Dasyprocta fuliginosa), il coati rosso (Nasua nasua) o il parrocchetto alicobalto (Brotogeris cyanoptera), specie protetta a livello globale dalla CITES – Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione – che lascia riflettere sull’importanza di una sensibilizzazione ambientale ancora molto lontana.
Ad un tratto, un breve ma acuto «uuh» interrompe questo flusso di pensieri e mi catapulta bruscamente nella realtà, immersa in un lembo di foresta ad ascoltare questo richiamo che echeggia nella finca, un’insolita abitudine kichwa per trovare le tracce di una persona persa di vista lungo il tragitto.
L’entrare in contatto con le persone delle comunità è ormai una certezza delle uscite in campo, vista la tendenza solidale di offrire passaggi in auto a chiunque ne manifesti l’esigenza anche solo da uno scambio tacito di sguardi… e poi ti ritrovi seduta accanto ad operai il cui obbiettivo del giorno è frammentare ulteriormente quest’habitat per fare da apripista e lasciare spazio al passaggio di nuovi condotti petroliferi.
Le giornate proseguono così, contornate da questi momenti intensi di introspezione che portano a una graduale presa di coscienza di questa realtà contrastante, tra lo sviluppo urbano di Tena e l’enorme divario delle zone rurali circostanti, che inevitabilmente va a smorzare quel mio sguardo entusiasta di una bellezza così significativamente effimera.
Non rimane che la sera, per decifrare e metabolizzare questo groviglio di pensieri e di emozioni, mentre il gracidio e il frinire costanti, mescolati al mormorio dei miei nuovi compañeros di Casa Bonuchelli, mi immergono nel sonno e mi ricaricano per un’altra giornata calda e umida nell’Amazzonia.