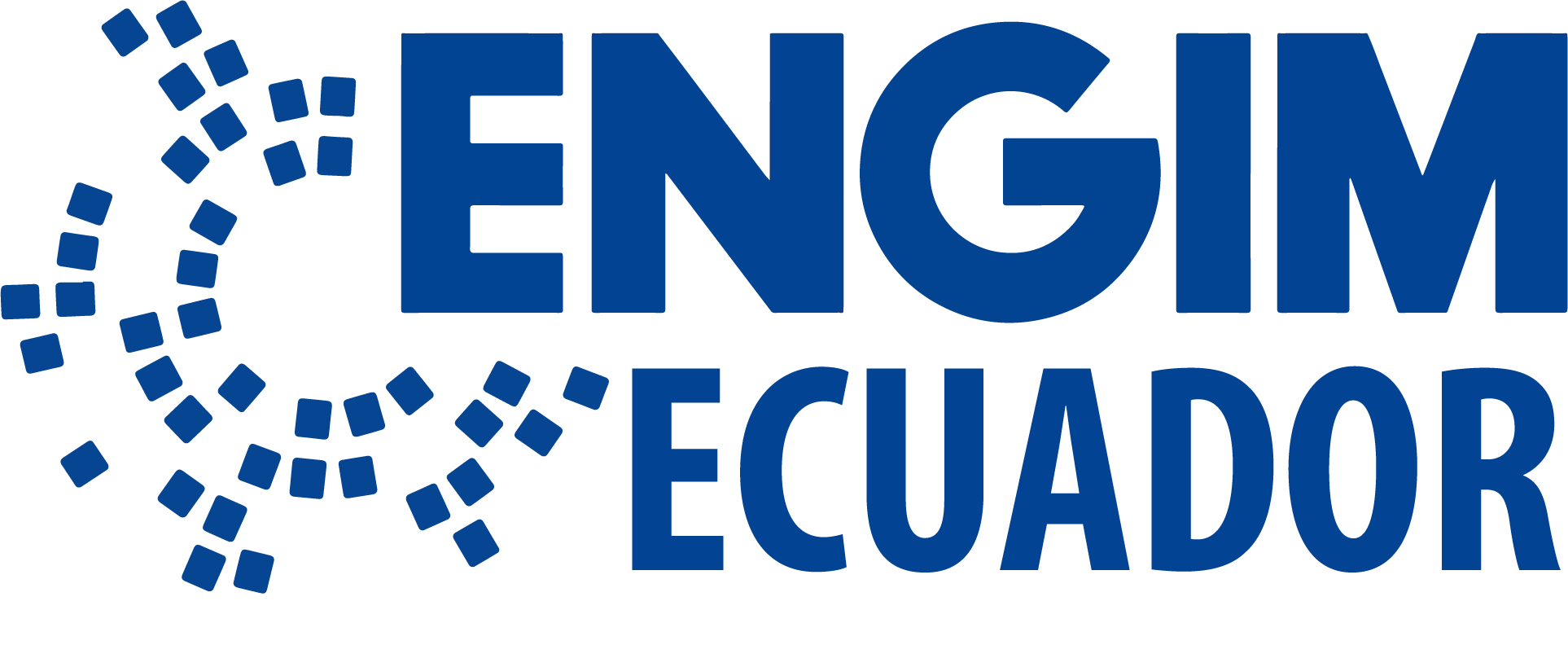di Gaia Di Ninno – Inserirmi nella casa d’accoglienza per donne vittime di violenza Wasi Pani a Tena è stato come un viaggio in un mondo totalmente diverso, pieno di svolte, alti e bassi, durante il quali ti sembra di non capire mai niente, anche quando pensavi di aver iniziato a capirci qualcosa. È un ambiente in continuo mutamento, un ecosistema in cui appena si stabilisce un equilibrio entrano in gioco nuovi fattori a scombussolarlo. È in atto un continuo lavoro di adattamento e armonizzazione di persone diverse, con le proprie peculiarità, necessità, problemi, sofferenze e rabbie chiuse in una casa quasi tutto il giorno. Si crea una situazione potenzialmente esplosiva ed il lavoro dell’equipe è quello non solo di prevenirne gli scontri ma anche di districare il più possibile le matasse di ognuna delle persone accolte.
Il lavoro che si fa in questi centri è sicuramente molto complesso e articolato, con una grande probabilità di fallimento costante. Quando sono entrata nella casa avevo già questa consapevolezza, ma ero totalmente ignara di come si traducesse in questo angolo di mondo. È stato un grande e faticoso lavoro di comprensione del contesto, delle dinamiche, delle persone, della cultura e della società, prima ancora di poter operare con un minimo di confidenza e poter apportare qualcosa. Il tutto è avvenuto nella tipica modalità ‘’impara a nuotare buttandoti in mare’’, ci sei dentro, o capisci come stare a galla o affoghi.
Il gruppo di donne e bambini si è approcciato a me sin dall’inizio in maniera semi-aperta e semi-chiusa. Già dai primissimi giorni sono stati molto socievoli, mi cercavano, mi facevano mille domande ma era più che altro un avvicinamento mosso dalla curiosità del diverso, ancora infuso di timore e timidezza. L’apertura però era accentuata dalla grandissima necessita di stimoli che il gruppo accolto dimostrava. La prima cosa di cui mi sono resa conto è stata la difficoltà che la struttura, gestita da pochissime persone e con pochissime risorse, avesse nel proporre tutte quelle attività necessarie al percorso che donne e bambini usciti da situazioni di violenza intra-familiare necessitano. Si garantisce la sicurezza, la sussistenza e il seguimento dei bisogni primari delle persone, ma con grande fatica si riesce ad accennare un pallido inizio di quell’enorme e difficile lavoro di ricostruzione della persona, di stabilizzazione psicofisica e di elaborazione di quegli strumenti di cui avrà bisogno al momento dell’uscita dalla casa e, di conseguenza, per la sua indipendenza.

La noia e la frustrazione provata dal gruppo ‘’parcheggiato’’ nella casa è stato il primo e costante bisogno che mi è arrivato addosso, ed è stato quello su cui ho cercato il più possibile di lavorare. Mi sono resa conto fin dai primi giorni che bastasse proporre una banale attività, come un gioco di gruppo o un’uscita al parco, per svoltare la giornata alle donne e bambini accolti. Col tempo i momenti di svago ma anche di doveri condivisi ci ha portati ad aprirci e conoscerci personalmente. Non è stato immediato, ma è avvenuto naturalmente. La condivisione della quotidianità è uno strumento potentissimo per avvicinare le persone in maniera profonda, anche quando la comprensione è ostacolata da fraintendimenti e limiti non solo linguistici (per molte delle donne accolte lo spagnolo è una seconda lingua di cui hanno poca dimestichezza, la prima è il kichwa amazzonico), ma anche culturali.
Avrei tante storie da raccontare di queste donne e bambini, tante storie di vita e di quotidianità, tante belle e tante brutte. È molto difficile anche solo sceglierne una esemplificativa dal momento che ognuna di queste persone ha un vissuto diverso e peculiare, anche se molte condividono esperienze e dinamiche simili. Purtroppo, in Ecuador persistono alti tassi di violenza sulle donne, a livello nazionale si stima che il 65% delle donne dai 15 anni in su abbia vissuta qualche tipo di violenza, che sia fisica, psicologica, sessuale o economica. Nella regione del Napo la percentuale arriva al 77,7%, di cui la grande maggioranza avviene all’interno della coppia o nell’ambito familiare.
In un contesto sociale e familiare connotato da una violenza diffusa, poiché esso si trasmette anche tra genitori e figli attraverso un’educazione che in primis legittima l’uso della forza, la maggior parte delle donne si sposa e/o ha il primo figlio già dai primi anni dell’adolescenza. Se da una parte persistono culturalmente, soprattutto nelle comunità rurali, pressioni familiari (se non forzature) affinché le figlie femmine, una volta raggiunto lo sviluppo, siano date in sposa ad un uomo, è anche vero che spesso sono le stesse a ricercare una via di fuga e di ‘’indipendenza’’ dalla famiglia violenta attraverso un matrimonio prematuro. Un altro fattore che alimenta fortemente l’incidenza di violenza nella regione del Napo è l’alcolismo diffuso nella grande maggioranza della popolazione maschile (ma non solo).
Infatti, più del 50 % delle donne accolte nella casa d’accoglienza che ho incontrato in questi 6 mesi hanno meno di 25 anni, una media di 3 figli. Escono da una relazione violenta con un marito che, quando torna a casa ubriaco (cosa che accade spesso) le denigra, minaccia, fino a picchiarle crudamente per un qualunque pretesto, che spesso è una richiesta di soldi per continuare a bere. Questa è solo la punta dell’iceberg della storia di molte donne che, fin da bambine, non hanno avuto accesso all’educazione poiché dovevano curare i fratelli o lavorare nella chakra. Adolescenti che hanno subito abusi sessuali dalle persone a loro più vicine. Adolescenti che hanno avuto figli prima ancora di poter maturare, munite soltanto di esempi violenti di educazione. Donne che hanno sempre provveduto al sostentamento economico della propria famiglia, ma a cui è stata negata la possibilità di gestire i soldi. Donne che alla fine hanno deciso di rompere questi legami di dipendenza, spesso per il bene dei figli, andando contro al volere della stessa famiglia e della comunità intera, poiché è normale che gli uomini abbiano ‘’dei momenti così’’.
Questa sembra essere la matrice di tantissime storie, anche se poi ognuna ha le sue variazioni sul tema. Accogliere, accudire e aiutare queste donne a ricostruirsi, per il loro futuro e quello dei figli, è un lavoro lungo, complesso che richiede molta pazienza. Non è solo necessario lavorare sui traumi vissuti, ma anche sui modelli di violenza e di inganno, spesso unico strumento per arginare gli abusi nella quotidianità, che hanno interiorizzato nel corso della loro vita. Il lavoro di ‘’ricomposizione’’ integrale della persona e di riprogettazione della vita con modalità differenti è necessario e cruciale per prevenire non solo il ritorno con l’abuser, ma anche la ricerca involontaria di persone che si comporteranno alla stessa maniera.

Questo grande lavoro, però, è affidato a poche case d’accoglienza che esistono sul territorio nazionale, e alle ancora più scarse presenti nella regione amazzonica. Molte sono fondate da pochi anni, non sono provviste delle risorse economiche, materiali ma soprattutto umane e professionali necessarie a compiere l’arduo compito a loro affidato. Le donne entrano nella casa aspettandosi che possa risolvere tutti i loro problemi immediatamente, invece si ritrovano, in un momento di grande stress e difficoltà psicofisica, di fronte ad un contesto molto difficile a cui doversi adattare. Dalle casette di legno in mezzo alla selva si ritrovano in una casa sovraffollata in città, piena di regole, doveri, impegni, visite mediche, psicologiche, con una richiesta di controllo e responsabilità sui figli che non hanno mai avuto. Allo stesso tempo faticano a vederne i benefici, soprattutto quando ci sono poche possibilità per coltivare anche i loro desideri, le loro aspirazioni future, la loro emancipazione.

Con queste donne e questi bambini sto condividendo momenti difficili ma anche momenti di grandissima bellezza, felicità e gioia. Mi hanno insegnato molto del loro mondo, delle loro tradizioni e della sterminata natura che popola questa zona e di cui io sono totalmente ignorante. Mi sorprendono sempre quando, camminando anche in città, riescano a riconoscere un frutto maturo o un’erba commestibile a distanze tali che la mia miopia non mi permette neanche di distinguere i contorni degli alberi. O quando gli stessi bambini partono alla rincorsa arrampicandosi su un qualche albero da cui iniziano a staccare frutti mai visti prima. Conoscono tutte benissimo la flora e la fauna del posto, cosa è commestibile e cosa no, che benefici possa apportare ogni pianta. Ma soprattutto, sono quei bei momenti, per lo più fuori dalla casa, in cui li ho visti tutti, donne e bambini, liberi di poter essere sé stessi, quelli che più rimarranno indelebili nella mia memoria.