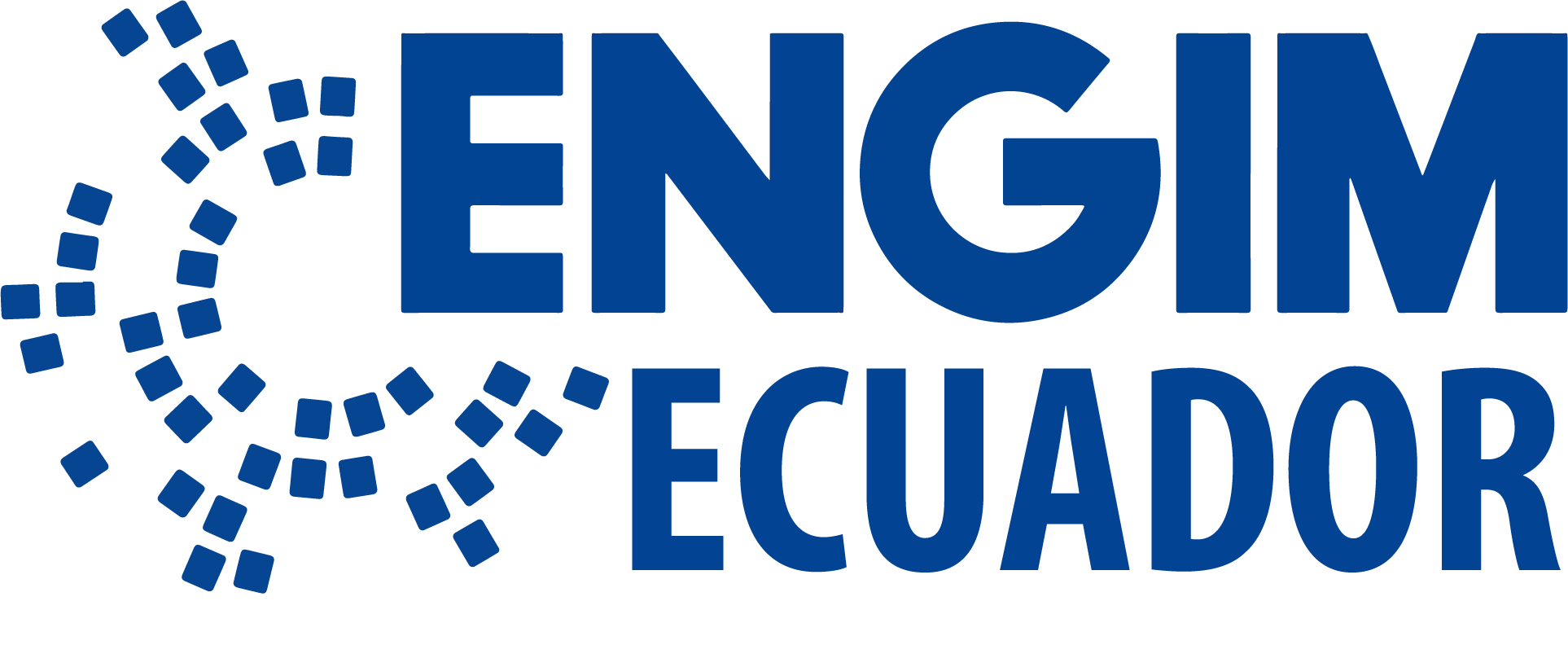di Matteo Carrozza – La scorsa settimana un ragazzino si è scusato del ritardo, spiegando che il fratello poco prima era stato pugnalato. Si è seduto e disinvolto ci chiede per favore una mano con i deberes. Un paio di settimane fa, una bambina si è scusata, mortificata, di non avere portato il quaderno con l’utile allo studio perché la mattina prima, al rientro da scuola, un delinquente ha fermato lei e la nonna derubandole di tutto, incluso il suo zainetto. Una mamma mi ha consegnato suo figlio chiedendomi di essere la sua figura paterna. Vivo a Quito da meno di due mesi.
Se la situazione socioeconomica dei barrios era già complessa, il coronavirus le ha dato il colpo di grazia. Il Quito post-pandemia non ha difficoltà a mostrare le ferite: la fame e l’analfabetismo sono presenze fisse delle interazioni sociali con la gente del barrio, il virus un demone che atterrisce ancora e traumatizza.

Eppure, tra le casette colorate e trasandate, tra i cani randagi e i loro coinquilini della strada “borrachitos”, tra il giallo dei numerosi taxi, tra il grigiore dello smog, tra le tienditas della frutta delle donne indigene, tra la musica latino-americana diffusa dalle casse dei negozietti, via via salendo lungo il barrio, si trova il CEIPAR.

Le hermanitas del centro sono così rispettate dalla comunità del barrio che spesso è difficile reggere la responsabilità di essere chiamato “tio” dalla gente, venendo associato a loro. Il rispetto, così sincero, certo non è casuale né forzato. Infatti, il lavoro svolto dalle donne del CEIPAR è immenso. Si immagini una fila composta da più di duecento persone, adolescenti, adulti, anziani, bambine e bambini, che ogni mattina ricevono un abbondante pasto gratuitamente, talvolta anche due o per una famiglia intera; vengano immaginate aule ricolme di bambini, bambine, ragazzini, ragazzine, mattina e pomeriggio, intenti a studiare o impegnare il tempo lontani dalla strada, prima di ricevere anche loro un pasto abbondante e fresco; si pensi ad un gruppo di donne che impegna la propria vita girando personalmente per le baracche dei più indigenti tentando di aiutarli come possibile: ci si provi, e comunque non si potrà arrivare a percepire l’energia e la grandezza di queste donne, né questo loro affetto tanto sincero e incondizionato.
Cammino ogni mattina tra le casette colorate e gli “hola tío” di Yaguachi cercando di essere forte quanto le persone che questo barrio lo vivono e lo combattono, chiedendomi talvolta che ragione ci sia nell’ostinarsi a donare a chi solo sa chiedere, senza sapere ricambiare. Una risposta definitiva non riesco ancora a trovarla. Mi piace pensare che la ragione sia nascosta in quelle persone che le casette colorate le vivono, le combattono, ma le amano, che prendono in giro il nostro accento da gringos ma che con orgoglio ci mostrano le stradine che abitano, i loro giochi tradizionali, il loro cibo tipico; nei bambini che si arrabbiano perché annoiati dallo studio, ma che dal CEIPAR non vogliono uscire, poiché intimoriti o stufi; nei loro abbracci ruffiani, ma con un fondo di riconoscenza.
Mentre rifletto su un’altra possibile risposta, magari meno retorica, continuo a tentare di insegnare a leggere a questi ragazzi che man mano mi insegnano ad innamorarmi di queste misteriose casette colorate.