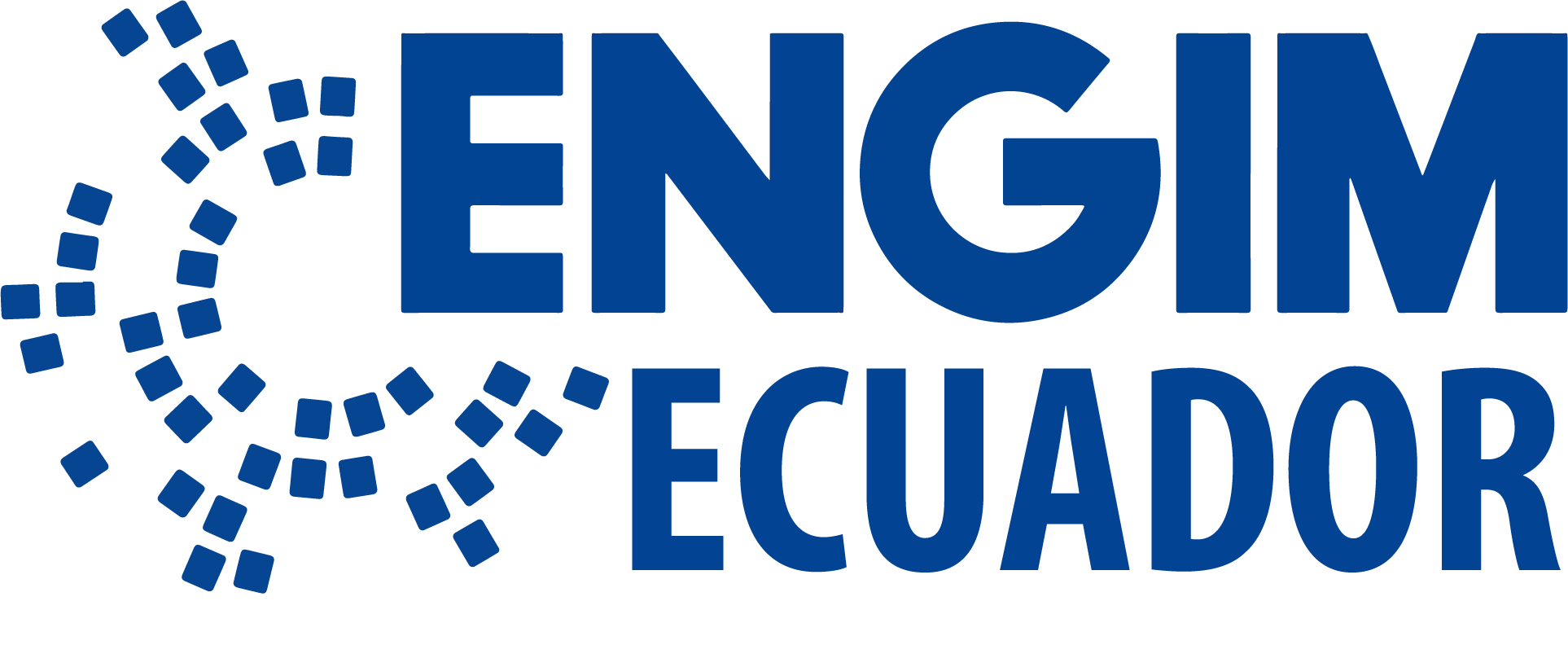di Silvia Martinez – Il sole del primo mattino è ancora basso, le strade ancora umide dall’acquazzone notturno, il sonno arretrato non permette ancora al mio cervello di elaborare pensieri sensati. Si parte per andare a monitorare le piantine in chissà quali “finche” delle comunità che costellano i dintorni di Tena. Non so quanto dovremo camminare in selva per raggiungerle, se ci saranno corsi d’acqua da attraversare saltando tra le pietre, terreni argillosi su cui sicuramente scivolerò o quanti verdissimi panorami potrò ammirare. Non sappiamo se una volta arrivati alle finche troveremo un terreno con la vegetazione completamente rasa al suolo da proprietari inesperti o uno spazio ben diversificato dove tutte le forme di vita sono in sinergia tra loro. È proprio questo tipo di finche che speriamo di trovare, che è poi l’obiettivo per cui quotidianamente ci impegniamo nel progetto di riforestazione. A vederla da un punto di vista antropocentrico invece, l’importanza di trovare ettari di selva dove la biodiversità possa esprimersi e dare luogo ad un’incredibile interdipendenza tra le specie lo si percepisce dall’umore che cala a picco quando ci troviamo a lavorare in una finca disboscata per fare spazio alle monocolture.
È invece in quelle giornate fortunate dove si capita in una finca dove la vegetazione è rigogliosa e ti sprigiona la sua energia facendoti sentire parte di essa che mi sento profondamente grata di poter vivere ed esplorare l’amazzonia ecuadoriana, dove la vita esplode e la diversità genetica si declina in mille strategie per reggere la competizione: formiche che invadono e saccheggiano le uova dai termitai, formiche conga tra le più dolorose al mondo, bruchi con fittissimi aculei urticanti che diventeranno farfalle di inconcepibili colori, chonte altissime con le loro inquietanti bande di spine, persino gli aranci qui si difendono con le spine. Una interessante eccezione a tutta questa competizione sono invece le api amazzoniche, che ancora non mi spiego come possano essere prive di pungiglione con tutta questa competizione da sostenere.
Dopo qualche ora di sole equatoriale e vari spostamenti accompagnati dai benificiari kichwa, (sempre seguiti dai loro fedelissimi e denutriti cani) la stanchezza inizia a farsi sentire, l’acqua calda della mia borraccia non placa la mia sete, il lavoro di monitoraggio inizia a diventare ripetitivo e alienante e subito arriva quel momento della giornata in cui inizio a chiedermi chi me l’abbia fatto fare. I suoni della natura fanno da sottofondo a sconnessi deliri da stanchezza che assorbono i miei pensieri: chissà come fanno gli abitanti delle comunità a vivere in queste case di legno immerse nel fango, in una condizione di dubbia igiene circondati da galline e “bichos” ingordi di sangue. Un giorno avrò il coraggio di chiederglielo, ma penso proprio che siano felici così…e come dargli torto nonostante queste irrilevanti scomodidità. Oppure inizio a ragionare sull’importanza dell’acqua in un posto dove te ne scorre così tanta davanti agli occhi ma tutta inutilizzabile per dissetarsi in quanto non potabilizzata, oppure poi alla frustrazione che mi provoca l’accettazione del fatto che quello del volontario è un ruolo marginale, bisogna sapersi fare da parte e impegnarsi quotidianament per apportare quell’unica minuscola goccia nel mare di criticità che affliggono il nostro sistema. Che è poi un po’ come piantare quell’unico albero sperando che un giorno, grazie allo sforzo di tanti, saranno poi sufficienti a riequilibrare i danni inferti all’amazzonia.

Il suono dei colpi di machete che un beneficiario kichwa scarica sui tronchi morti che intralciano il nostro cammino mi riporta alla realtà. Provo a scambiarci due chiacchiere ma la conversazione non si fa mai troppo profonda, forse per colpa mia che ancora non ho trovato la chiave per accorciare la distanza tra di noi. Il loro atteggiamento è mite e mesto, il loro genuino pudore viene meno solo quando sputano rumorosamente a terra accanto a te facendolo sembrare una cosa normale, la loro gentilezza è disarmante e la loro lingua incomprensibile.

Alzo lo sguardo e ancora non smetto di stupirmi degli alberi costellati da nidi oropendule, del verso delle scimmie urlatrici o delle mille bormeliacee appollaiate su alberi di 30 metri, che chiamarli alberi poi è riduttivo con tutta la vita ci brulica sopra, dentro, sotto.
Abbasso lo sguardo e ammiro le formiche tagliafoglie che sfilano ordinate mentre trasportano i pezzettini di foglia che hanno sfortunatamente ritagliato dagli aranci appena piantati. Li useranno come terreno di crescita per il fungo di cui si nutrono e che coltivano nel loro formicaio in monocoltura. In quanto monocoltura, questa è suscettibile a vari parassiti tra cui un fungo parassita specializzato che potrebbe rendere vano tutto il loro lavoro. Per ovviare a questo problema alcune specie di tagliafoglie hanno evoluto il geniale sistema di ospitare dentro di sé un ceppo di batteri, che nutrono con specifiche ghiandole, e che inibisce la crescita del fungo parassita permettendole così di mantenere sano il fungo coltivato.
Dopo essermi riempita gli occhi di tutta questa roba straordinaria arriva puntualmente un kichwa, magari a piedi nudi con il suo immancabile machete a tagliarti un casco di platani, aprirti un frutto di cacao gigante da cui ciucciare la polpa dei suoi semi o ad offrirti una stra-fermentata chicha di yucca che non mi permetto mai di rifiutare nonostante il dissenso proveniente dal mio apparato di digerente.

Il lavoro di monitoraggio continua, fotografiamo tutte le piante che avevamo consegnato e che i beneficiari hanno piantato nelle loro finche. È un lavoro semplice, non richiede un grande sforzo intellettuale, ma per fare la vita da campo qui è indispensabile un grande spirito di adattamento. Il sole può essere molto forte e l’umidità ti si appiccica addosso, poi arriva la pioggia tropicale, che potrebbe anche essere piacevole se non fosse che mi sono dimenticata l’impermeabile e non ci resta che ripararci con una foglia staccata da un platano.
Stremata, sporca di fango e sudore misto a odore di selva e umidità, torno a casa con la pelle piena di punture di inclassificabili insetti ma lo zaino pieno di rossissimi fiori di jamaica pronti da infondere, frutti di achote con cui imbrattarsi la faccia, kili di pilce che da inutili palle maleodoranti si trasformano in oggetti dalle mille funzioni o manciate di hierba luisa che ridona un odore accettabile al mio zaino.
Ed è così che tutti i giorni cerco di tenere a mente di non abituarmi a tutto questo, di farne indigestione, di mantenere sempre la meraviglia ad accompagnare il mio sguardo e non dimenticarmi neanche per un giorno la fortuna che ho di poter vivere ogni giorno la Kawsak Sacha, selva vivente, e di quanto sia fondamentale preservarla.