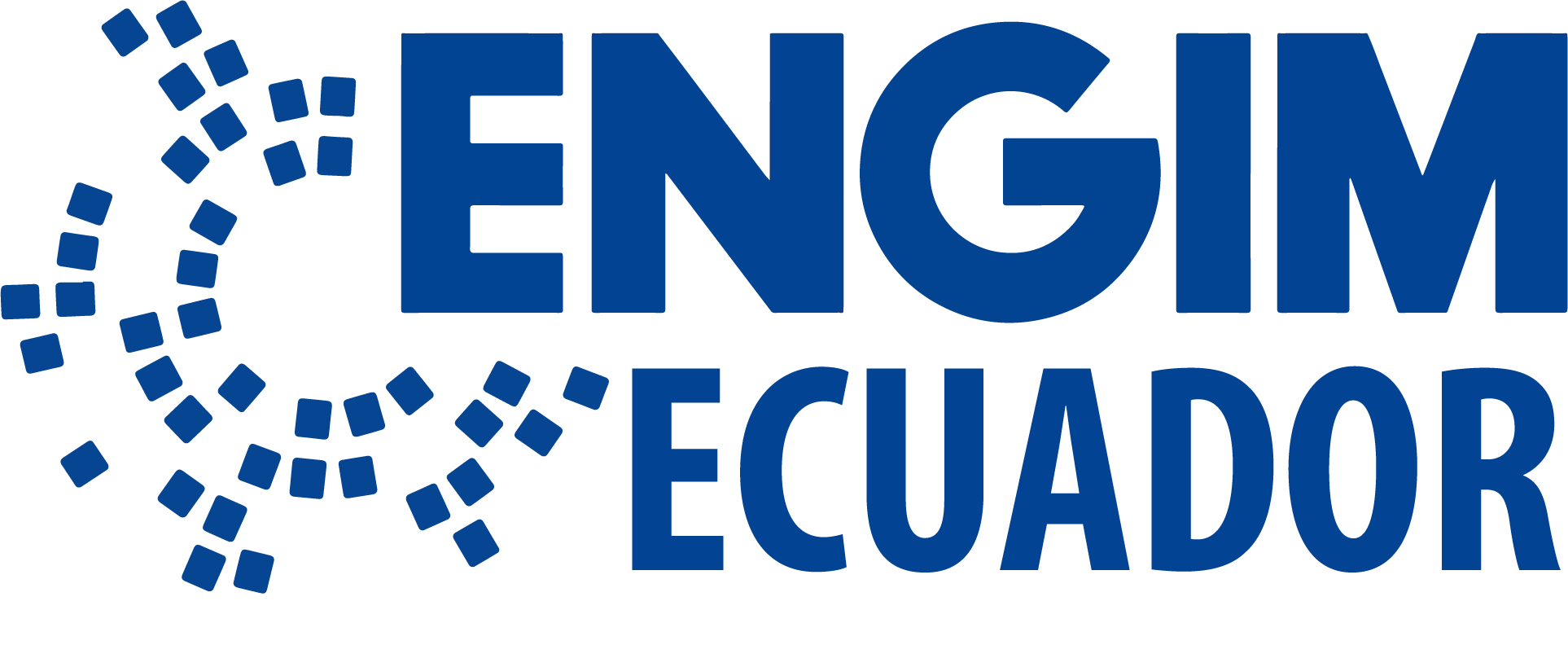di Chiara D’Arco – “Sembrando Semillas” è il nome assegnato al percorso di educazione ambientale proposto, a partire da novembre 2021, nelle classi secondarie di alcune scuole comunitarie della provincia del Napo. A dare forma a questo progetto siamo state in quattro, in un periodo che ha rappresentato la prima fase di adattamento della nostra esperienza di Servizio Civile.
A pochi giorni dal nostro arrivo e ancora in balìa di mille cambiamenti e delle emozioni che questi provocano, ci siamo ritrovate a progettare un percorso di educazione ambientale a partire da zero. Nonostante alcune di noi avessero già avuto esperienze pregresse di questo tipo in Italia, era chiaro che ci trovassimo di fronte a qualcosa che per tutte fosse completamente inedito. Avremmo dovuto abbandonare le metodologie e i riferimenti fino a quel momento applicati e analizzare il contesto che, carico di tutte le sue complessità, ci si proiettava dinanzi. Per un po’ questa è stata la nostra sfida personale.
Le comunità del Napo non solo vivono nella foresta, ma vivono della stessa, nutrendosi di ciò che offre e ricavando l’esiguo introito economico dai prodotti che riescono a produrre nella chakra, una sorta di foresta coltivata. Ero consapevole di questo, ma non avevo la minima idea di come potessero essere gli alunni, di come approcciarmi a loro e soprattutto, faticavo ad immaginare che grado di consapevolezza avessero dell’ambiente circostante. Sono nati a strettissimo contatto con la natura, di sicuro la conoscono molto meglio di me- pensavo- che cosa potremmo mai insegnare noi, appena arrivate, a ragazzi che qui ci sono nati e cresciuti? Mille volte mi sono messa in discussione, sulla coerenza nella scelta dei temi da trattare, su quale fosse il senso di fare educazione ambientale in amazzonia, e soprattutto sull’essere o meno all’altezza di tale incarico.

Vivere in un contesto così complesso all’inizio crea una forte confusione. Le poche certezze con cui sono partita dall’Italia hanno cominciato a sgretolarsi a mano a mano che toccavo con mano la nuova realtà, mi ci muovevo dentro e cercavo di starvi a galla. Con che coraggio avrei potuto annunciare agli alunni di queste scuole che per preservare il pianeta è necessario ridurre il consumo di carne, fare la raccolta differenziata, ricordarsi di spegnere la luce quando possibile e non sprecare l’acqua se, nella maggior parte dei casi: uno dei pochi pasti giornalieri garantiti è a base di riso e pollo, la separazione dei rifiuti non è contemplata dal governo ecuadoriano (anzi, in alcune comunità nemmeno ci arriva l’iconico camioncino della spazzatura), non tutte le case hanno l’elettricità e l’unica acqua a cui molti di loro hanno accesso è quella piovana che, se malauguratamente dovesse mancare, viene sostituita dall’acqua del fiume, contaminato com’è.
È con queste riflessioni che non hanno tardato a palesarsi le problematiche su cui avremmo dovuto focalizzarci.
La prima esperienza è stata in una scuola fiscomisional (ovvero finanziata in parte da fondi statali e in parte dalla chiesa cattolica) a pochi chilometri da Tena, nel cantone di Archidona. La scuola si chiama Juan Leon Mera e in quel periodo, a causa dell’allarme covid, era frequentata in maniera semi presenziale, soltanto due volte a settimana, dai bambini della vicina comunità di Lushian.
Prima di iniziare i laboratori abbiamo avuto un incontro con l’insegnante e responsabile della scuola. Qui abbiamo deciso di occuparci di due delle cinque classi che la scuola ospita: il settimo e l’ottavo grado, rispettivamente ragazzi di undici e dodici anni. Il ciclo sarebbe durato in totale otto settimane per un incontro a settimana. L’insegnante si è dimostrata fin da subito entusiasta della nostra presenza e alla fine ha voluto omaggiarci con dei succhi di frutta iper-zuccherati che il governo ecuadoriano consegna a tutte le scuole del paese. Non mi stupisce che gli ecuadoriani di tutte le età abbiano un evidente dipendenza da zucchero.
La scuola di Lushian ha una struttura semplice, a pianta rettangolare in mezzo al verde. Le pareti sono in cemento e il tetto in lamiera, come la maggior parte delle case qui. La prima cosa che mi è saltata all’occhio arrivata in questa scuola è che non ci sono vetri alle finestre, ma solo sbarre in ferro. L’aula è un luogo aperto, sensibile ai rumori e ai suoni, con l’acqua che entra e bagna i cartelloni attaccati al muro quando piove troppo. La porta in legno fa fatica a chiudersi; attraverso la fessura sbirciano timidi ma curiosi bambini più piccoli, o entrano di soppiatto cani che non si sa bene di chi siano.
Non sapevamo che il giorno prefissato per il primo laboratorio fosse anche quello designato per il richiamo del vaccino contro il covid. Tra l’indifferenza di tutti, una gallina entra in aula e si mette a razzolare al centro della classe mentre la dottoressa alla cattedra, senza alcun tipo di dispositivo medico, chiama all’appello i bambini che ancora devono ricevere l’iniezione. A sentire il suo nome, uno di loro piagnucola mentre controvoglia si alza la manica della maglietta. Io intanto assisto a questa scena e mi stupisco proprio del fatto che ormai non mi stupisco più di tanto. Sono entrata in questa realtà in una maniera così totalizzante che a volte penso di non aver avuto neanche il tempo di impressionarmi per certe cose.

Ricordo la classe di Lushian con affetto, con l’emozione dei primi approcci e delle prime esperienze. È stato un incontro di prime volte: per noi, che abbiamo sperimentato il nostro percorso e per loro, con persone di una ONG, bianche, gringas che si presentano nella loro scuola. L’approccio che abbiamo scelto per i nostri laboratori è quello, se vogliamo chiamarlo con un certo tono, maieutico. Non volevamo “insegnare” in modo convenzionale, di quello se ne occupa già il sistema scolastico classico, ma volevamo che fossero le bambine e i bambini, attraverso le loro impressioni, i loro pensieri e intuizioni, ad arrivare alle conoscenze. In altre parole, avevamo come obbiettivo quello di stimolare la loro creatività e immaginazione attraverso attività pratiche che li invogliassero al lavoro di gruppo e li guidassero verso la formulazione di un principio specifico per ogni incontro. Questo si è rivelato fin da subito molto difficile. Le ragioni sono tante, tutte vere. La pandemia, che li ha disabituati ad andare a scuola per due anni; la timidezza nei nostri confronti, persone esterne che non parlano bene la loro lingua e che sono percepite come molto lontane da loro; la differenza tra questo tipo di approccio e quello a cui sono stati abituati a scuola; la tendenza ad assimilare concetti passivamente senza farsi troppe domande. Inizialmente, i bambini di questa scuola erano molto chiusi. Il primo giorno non sono nemmeno riuscita a sentire i loro nomi da quanto li pronunciassero con voce sottile, sguardo basso, quasi bisbigliandoli tra sé e sé. Inizialmente non avevano domande da porci e non sembravano particolarmente entusiasti o incuriositi dalla nostra presenza. Era impossibile ottenere un feedback da loro e per questo mi risultava difficile capire se il messaggio che cercavamo di trasmettere gli stesse in qualche modo arrivando oppure no.
Con il passare del tempo mi è sembrato che i bambini avessero iniziato ad acquisire una certa fiducia nei nostri confronti e finalmente a esporsi un po’ di più nel farci qualche domanda sul nostro paese d’origine o su come si pronunciassero alcune parole in italiano. Certo, a mano a mano che si abituavano alla nostra presenza iniziavano anche a prenderci in giro e a farci versi per il nostro accento, doveva risuonare buffo alle loro orecchie. Questa situazione mi ha spiazzata diverse volte, non sapevo bene come reagire ma era molto snervante. Dopo un ampio respiro e con pazienza provavo a spiegare che, come loro, siamo in un processo di apprendimento, di una nuova lingua, una nuova cultura. Mi guardavano ammutoliti. Ho pensato che forse, anche solo per quell’istante, loro si stessero immedesimando nei nostri panni. La distanza tra noi mi sembrava accorciarsi un po’.

Di seguito proverò a descrivere brevemente quello che secondo me è il contesto con cui ci siamo trovate davanti. La realtà è probabilmente molto più complessa di così, io la sto soltanto semplificando.
L’amazzonia ecuadoriana, a causa dell’abbondanza delle sue risorse naturali, è stata caratterizzata negli ultimi secoli da uno sfondo di forti tensioni ideologiche e politiche. Dal processo di invasione, appropriazione e violenza meglio conosciuto come colonizzazione, questa regione si è convertita in uno scenario di vari conflitti di interesse. Le conseguenze di tali conflitti hanno portato purtroppo ad una drastica alterazione della relazione tra gli abitanti nativi dell’amazzonia e la natura. Questo ha fatto sì che oggi l’etnia kichwa, forse quella che più di tutte è stata a contatto con queste influenze (prima ancora l’impero Inca, poi i colonizzatori spagnoli e infine i missionari), appaia socialmente e culturalmente molto complessa. Inizialmente, i kichwa di questa zona formavano popolazioni nomadi e vivevano dispersi in gruppi familiari lungo i fiumi. Erano un popolo di abili cacciatori e raccoglitori, grandi conoscitori di piante medicinali. Costruivano capanne temporanee di bambù guadua e paja toquilla. Per nutrirsi cacciavano gli animali della foresta e coltivavano yucca e platano. Ci rimanevano in media un anno, il tempo necessario per raccogliere i prodotti della propria coltivazione. Poi, quando si accorgevano che il cibo iniziava a scarseggiare, si spostavano per raggiungere nuovi territori. Davano il tempo alla foresta di rigenerarsi per poi ritornare negli stessi luoghi. Ad attenderli era il vasellame di ceramica che loro stessi erano abili nel realizzare con l’argilla dei fiumi e che interravano per preservarlo nel periodo della loro assenza. Si nutrivano quindi di ciò che offriva la foresta e basavano la loro intera sopravvivenza sulla relazione di scambio paritario con l’ambiente che li ospitava. Fu alla fine del diciannovesimo secolo che, per iniziativa dei missionari, i nuclei familiari iniziarono a raggrupparsi creando le attuali comunità stanziali. Adesso i kichwa quasi non mangiano animali selvatici, perché non più così abbondanti e tra l’altro ne è vietata la caccia dal governo ecuadoriano. In piscine scavate nella terra argillosa allevano tilapie, pesci africani che hanno il vantaggio di crescere velocemente, eletti a cibo dei giorni di festa. Come se non bastasse, nei tempi più recenti si è affermato a spada tratta il fenomeno dell’urbanizzazione. Tena è una città in irrefrenabile processo di espansione. Ho l’impressione che tutto questo li releghi sempre più ai margini della società urbanizzata, vittime di un sistema che sta provocando la perdita progressiva della loro identità e della saggezza del popolo di una volta. È ai margini della società che subentra la mancanza di educazione, e come un effetto a cascata, la povertà, l’alcolismo, la violenza, il lavoro minorile. La maggior parte delle famiglie vive alla giornata e pur di racimolare qualche soldo sono disposti a lavorare nelle miniere di oro o nei pozzi di estrazione petrolifera. I loro sistemi agroforestali ancestrali si trasformano in monocolture di yucca, platano, cacao o caffè quando il resto degli alberi vengono tagliati per ricavare contanti.
Parlare di questi temi additandoli come il male assoluto quando rappresentano l’unico modo che alcune famiglie hanno per sostentarsi, ecco, proprio non me la sentivo.
Nel primo incontro abbiamo deciso di affrontare il tema della materia organica/inorganica e del compostaggio.
Immaginate di non aver mai conosciuto la plastica, e di aver sempre vissuto di frutta, verdura e carne proveniente da raccolta e caccia. Tutto materiale organico. Niente imballaggi. I rifiuti, la buccia di banana, è normale gettarli nell’ambiente. La natura segue il suo corso e li rimette in circolo. È un bene che sia così. Qualora però invece del frutto, vi trovaste nelle mani una caramella, una bottiglia o una lattina, fareste lo stesso. Mangereste la caramella e buttereste via la carta nella natura. Solo che ora, inconsapevolmente, state facendo un danno. È un po’ quello che secondo me è accaduto qui. Di fatto, in Ecuador non esiste ancora un sistema pubblico di separazione e riciclaggio dei rifiuti. Non è difficile trovare involucri di cannucce e bustine di plastica disseminate un po’ dappertutto intorno alla scuola. I bambini buttano a terra i contenitori vuoti del latte alla fragola che passa il governo con la stessa nonchalance degli adulti che invece lo fanno con le lattine di birra, mentre assistono ad una partita di ecuavolley.

Negli incontri successivi, alcuni degli argomenti trattati hanno riguardato la biodiversità, in cui ci siamo focalizzate nello specifico sulla grande varietà dei semi amazzonici e poi ancora, l’importanza degli alberi per le loro radici capaci di filtrare l’acqua e trattenere gli argini dei fiumi, i pigmenti naturali, il riciclo creativo e il cambiamento climatico.

Dopo Lushian, abbiamo riproposto il percorso di educazione ambientale in altre due scuole di comunità, adattandolo alle loro esigenze. Con l’esperienza maturata anche il progetto si è andato evolvendo, affinandosi sempre più per aderire meglio al contesto vissuto. All’inizio pensavamo di essere sole, poi abbiamo scoperto con sorpresa che a Tena esistono associazioni di giovani volontari che si occupano di educazione ambientale. Con loro abbiamo collaborato all’interno di laboratori specifici.

Il proposito di questo tipo di educazione è stato quello di sensibilizzare gli alunni e le alunne sulle questioni ambientali, motivarli a trovare soluzioni anche mediante un dialogo che esca dalla dimensione di aula scolastica e che si estenda alle famiglie e alle comunità. Per raggiungere questo obbiettivo abbiamo organizzato giornate di riforestazione che coinvolgessero tutta la scuola e le famiglie degli alunni.

Da questa esperienza ho capito che conoscere è l’unico modo per amare. Parlare del proprio territorio è il primo passo per proteggerlo e l’educazione ambientale è un ottimo strumento attraverso cui farlo. Attraverso questo progetto, nel nostro piccolo, abbiamo provato appunto a “sembrar semillas”, cioè seminare dei semi, letteralmente certo ma anche e soprattutto simbolicamente. Dare piccoli spunti che le cose si possono fare anche diversamente di così. Che piccoli passi sono possibili anche in un contesto tanto difficile, consapevoli che i cambiamenti più duraturi nascono dal basso, con costanza un passo alla volta. Nelle mani di questi ragazzi e di queste ragazze c’è tutto il potenziale per poter migliorare il futuro, così come un semino minuscolo ha dentro di sé tutto il potenziale per diventare un grande ceibo.