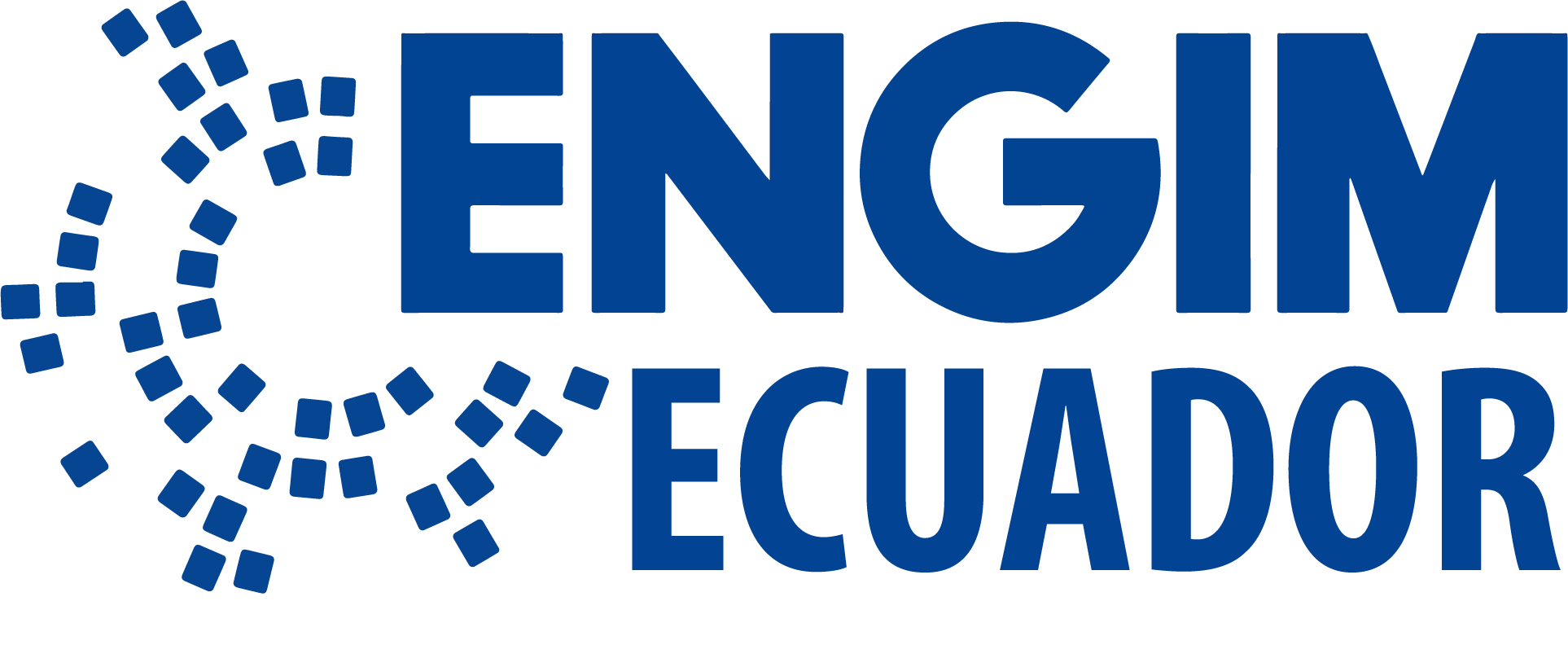di Anna Beretta. Grazie all’Associazione Ishpingo, già da diversi mesi ho la possibilità di visitare molte comunità differenti per partecipare ai loro progetti di riforestazione comunitaria. È un mattino di marzo, le nuvole sono ancora rade, ma qualcosa mi dice che a un certo punto della giornata pioverà. È abbastanza tipico in questa che è la stagione considerata invernale: si può passare improvvisamente da un cielo terso a un acquazzone battente.
Con gli occhi ancora impastati dal sonno raccolgo il mio casco e attendo fino all’arrivo di Flor che a bordo della fiammante moto “Roja”, ci condurrà alla minga di oggi (minga in kichwa è il termine con cui si definisce la forma di lavoro comunitario che coinvolge tutti gli appartenenti a una comunità o ad un gruppo).
Siamo dirette alla comunità Awatino, un’ora da casa. Lì ci aspettano gli abitanti del barrio “Il Guadual” che ho già avuto modo di incontrare nella minga della scorsa settimana. Il nome del barrio viene dalla guadua che forma un piccolo boschetto vicino alle case: una specie di bambù autoctono, resistente e versatile, utilizzato come materiale da costruzione. La mattina sarà dedicata a enfundar, ossia riempire di terra le fundas (sacchetti di plastica utilizzati per ospitare le piante) che collocheremo nel vivaio comunitario, dove pian piano trapianteremo le piantine che di lì a qualche mese saranno messe a dimora nei terreni dei beneficiari.
Il rombo della “Roja” sancisce l’inizio della giornata. Dalla perimetral (una sorta di piccola circonvallazione) osservo Tena dall’alto, ammantata nelle nuvole e bordata ad ovest dal blu cupo della catena andina.
Presto il paesaggio diventa verde intenso e la selva si apre a perdita d’occhio correndo sotto il mio sguardo; penso quanto sono fortunata a vivere in un posto così bello. Lo penso tutti i giorni, ormai.
Gioco con gli occhi a riconoscere le piante che vedo: piante di guaba cariche di lunghi bacelli affusolati, un albero di chuco punteggiato di fiori rossi come piccoli uccelli e poi eliconie, caballeros de la noche, arbusti di ibisco, palme di ogni sorta e, d’improvviso, l’immenso ceibo pluricentenario che svetta maestoso sulle nostre teste ricoperto di bromelie e liane di ogni sorta.

Scrutando giornalmente questi paesaggi, mi sono resa conto che anche qui, all’equatore, dove non esistono le stagioni (ci è stato insegnato alle scuole elementari) possiamo percepire una stagionalità caratterizzata dai cicli peculiari di ciascuna specie vegetale. La selva non è sempre e solo verde. Cambia, fiorisce e matura in momenti ben precisi. Marzo è incredibile da questo punto di vista. E qui occorre una parentesi sui frutti nuovi che ho scoperto questo mese! È il momento del zapote, frutto fuori beige e dentro aracione acceso, dal sapore ibrido tra una zucca e un mango, del paso, castano-rossastro fuori e giallo dentro, burroso come un avocado, ma più croccante, del cacao blanco o patas muyu (in kichwa), un frutto grande come un melone, dall’aspetto simile a un uovo di drago, la cui polpa sa di casa della nonna e di cui si mangiano i semi, ottimi fritti o tostati. È anche la stagione della chonta, la palma più nominata dalla cultura kichwa (ne esistono di diverse, quattro sono raccontate in questa canzone dal titolo Chuscu chunda “quattro chonte”). Ammantata dalle spine più dolorose che abbia mai toccato, la chonta ha diversi usi. Se ne consumano i frutti rossi, con cui si prepara la chicha, e il palmito, midollo fresco e croccante che potrebbe vagamente ricordare un finocchio. Dai tronchi si ricavano due cose: i pali portanti delle case perchè la chonta ha un legno molto duro, e il chontacuro, la larva cicciotta del coleottero Rhynchophorus palmarum, che si sviluppa nei tronchi abbattuti e che è considerata un’autentica prelibatezza.

Ma torniamo alla mia traversata mattutina.
Lungo il nostro cammino costeggiamo diverse comunità, piccoli villaggi con case in legno sopraelevate, ed è qui che compaiono i campi di yuca, platano, mais e dove polli indomiti atraversano la strada correndo. Tutti indizi che mi raccontano gli alimenti di base degli abitanti di questi luoghi.
Il sole ha fatto capolino tra le nuvole, quanto basta per permettere ai coltivatori di cacao di disporre i loro chicchi a seccare sull’asfalto, a lato strada, incorniciati da grosse pietre ad impedire spiacevoli incidenti. L’odore del cacao fermentato si mischia a quello del motore e dei fiori, un boquet bizzarro, che mi sa di Amazzonia.
Una signora in giubbino catarifrangente ci fa segno di accostare: tocca fermarsi a causa di alcuni lavori in corso, onnipresenti su queste strade: l’asfalto può molto poco contro l’intensità del clima amazzonico e la manutenzione è d’obbligo!
Nell’attesa mi guardo attorno e, meraviglia, compare un piccolo gruppo di chichicos (tamarini della specie Leontocebus nigricollis) mangiando chissà quali frutti tra le fronde. È la prima volta che vedo queste scimmiette da quanto sono qui e non vedevo l’ora accadesse! Mi commuovo un po’. Un’ultima occhiata al piccolo muso bianco sul nero della pelliccia e la Roja riparte.
La strada asfaltata lascia spazio allo sterrato e il paesaggio si svuota: passiamo accanto a un campo in cui negli ultimi anni è stata praticata un’intensa attività estrattiva. Non ci sono alberi, solo un prato spelacchiato e qualche balsa pioniera che si riprende la terra. La mineria, è da sempre praticata dalle comunità kichwa del Napo con l’utilizzo della batea un contenitore conico che permette di “lavar oro”. Un’attività, tra le varie possibili, con cui le persone tentano di sbarcare il lunario senza apportare danno all’ambiente. L’attività estrattiva tradizionale, però, sta progressivamente venendo rimpiazzata da quella che impiega macchinari e sostanze chimiche con la conseguente deturpazione del paesaggio, che osservo, la distruzione dei letti dei fiumi e la contaminazione delle acque.

Quando, a fatica, il motore sputacchiante della Roja ci permette di scalare incolumi la salita di Awatino, so che il nostro viaggio è giunto al termine. Siamo a destinazione. Nel vivaio ci stanno aspettando tutti: una ventina di persone, coppie di uomini e donne, senza contare la moltitudine di bambini e bambine sparpagliati qua e là. Ciascun membro del gruppo ha portato con sé un sacco di terra negra, ricca di nutrienti, per formare la montagna che troneggia al centro del vivaio, il nostro personale Chimborazo (la montagna più alta dell’Ecuador coi suoi 6310 metri). Io e Flor salutiamo tutti i presenti, stringendo loro la mano e dicendo Ali pungha, buongiorno in kichwa. Naturalmente ci dividiamo i compiti: chi comincia a riempire le fundas di terra, chi si prodiga a costruire, con pali di guadua, gli spazi in cui verranno disposte le fundas piene e chi già parte alla ricerca di nuova terra.

Nel domandarci com’è andata la settimana e che c’è di nuovo, improvvisamente, Janeth mi chiede, senza troppo girarci attorno, se mi ricordo i nomi di tutti i partecipanti alla minga. Aimè, la risposta è un no, e mi tocca ammetterlo! Però prometto che mi impegnerò al massimo per conoscerli tutti entro la prossima minga, e che, se mi permetteranno di fargli alcune foto, questo sarò molto più semplice! La mia proposta genera un’ilarità generale e l’atmosfera mi diventa subito familiare. Ho il lasciapassare per mettere da parte l’imbarazzo e catturare gli istanti di questa giornata.
Con le mani nere di terra, chiacchieriamo del più e del meno, mi chiedono da dove vengo e quanti anni ho. Ventotto, rispondo. Erika e Tania, entrambe col pancione, mi raccontano che, per loro, non avere figli alla mia età è molto strano. Le donne di questa comunità sono praticamente tutte sulla trentina ed è normale che abbiano già 2 se non 3 bambini.
Allora interviene la signora Maria, matriarca della comunità che prende la parola, sommessamente, quasi sottovoce. Mi racconta che lei si è sposata tardi, a trent’anni, perché da giovane aveva prima studiato, poi lavorato per una Missione e il matrimonio aveva dovuto aspettare. Ho l’impressione che me lo racconti con orgoglio, dato dall’aver intrapreso un percorso differente da quello standard, e mi sembra ne vada molto fiera. C’è altro che inorgoglisce Maria, la sua artesanía. Come molte donne da queste parti, realizza prodotti di artigianato, orecchini, collane, braccialetti, borse utilizzando fibre e semi naturali ricavati direttamente dalla chakra. Nella nostra chiacchierata apprendo come tutte le lavorazioni proprie della sua arte, Maria sia riuscita ad insegnarle ai suoi figli e alle sue figlie, senza distinzione, perché “è importante”. Mi prende per mano – solo un momento, dice – e mi guida nella sua casa per mostrarmi le sue creazioni. Mi chiede di scegliere qualcosa e mi regala un bellissimo paio di orecchini e, vedendo il mio interesse, una chigra, una borsa di rete realizzata intrecciando fibre di chambira.
Felice come a Natale torno al vivaio, carica per riempire decine di fundas, ma i miei collaboratori e le mie collaboratrici hanno un altro compito per me. Tania e Elsy mi chiamano a gran voce, aswamama! Vogliono che le aiuti a preparare la chicha (aswa in kichwa), la bevanda di yuca fermentata che qui viene consumata giornalmente, a volte come sostituto dei pasti, “lo yogurt amazzonico” dice ridacchiando Tito (esiste anche la chicha di chonta, ma è meno frequente di quella di yuca). La preparazione consiste nel diluire un panetto di chicha fermentata che è stata cotta e schiacciata qualche giorno prima. Apprendo l’arte quindi, e poi mi tocca servire la bevanda, secondo uno schema semplice, ma preciso: a turno servo a ciascun partecipante una ciotola piena fino all’orlo, il commensale beve finchè vuole e poi mi restituisce la ciotola, ringraziandomi solamente alla fine. Sciacquo il bordo della tazza, la rimbocco e servo al successivo. Finito il giro un sorso tocca pure a me, che per la giornata sono diventata la aswa mama, la donna della chicha.

La minga prosegue, tra buffi aneddoti raccontati un po’ in kichwa e un po’ in spagnolo, contando i lombrichi che sbucano dalla terra, mentre apprendo le storie che si celano dietro ai soprannomi dei presenti. I bambini trotterellano giocherellando con la terra e imitando il lavoro dei genitori. Ci sorprende quell’acquazzone che avevo predetto al mio risveglio, ma passa presto e torna il sole del mezzogiorno, a chiudere il nostro lavoro della mattinata. Il vivaio è quasi pieno e con le 834 fundas di oggi abbiamo ampiamente raggiunto il nostro obiettivo. Viene dichiarata la fine della minga e nella gioia generale ci dirigiamo verso la nostra zuppa di pollo, accompagnata da platano e yuca bolliti: una piacevole certezza!

Con le pance piene ci salutiamo. Nei momenti ufficiali la formalità è d’obbligo e Rodrigo, l’anfitrione, ringrazia tutti chiamandoci estimadas y estimados – stimate e stimati. Grata della giornata e volenterosa di imparare una volta per tutte i nomi dei miei nuovi compagni, propongo una foto di gruppo, i bambini impazziscono di gioia e si mettono in posa (per questioni di privacy non posso mostrarvi la foto, ma vi assicuro che i 15 bambini che ahnno posato per me sono tremendamente fotogenici). Per gli adulti, più reticenti, sarà per la prossima volta. A bordo della Roja saluto il Guadual con il cuore pieno e penso che non vedo già l’ora di ritornare per poter imparare ancora tante cose da queste persone.