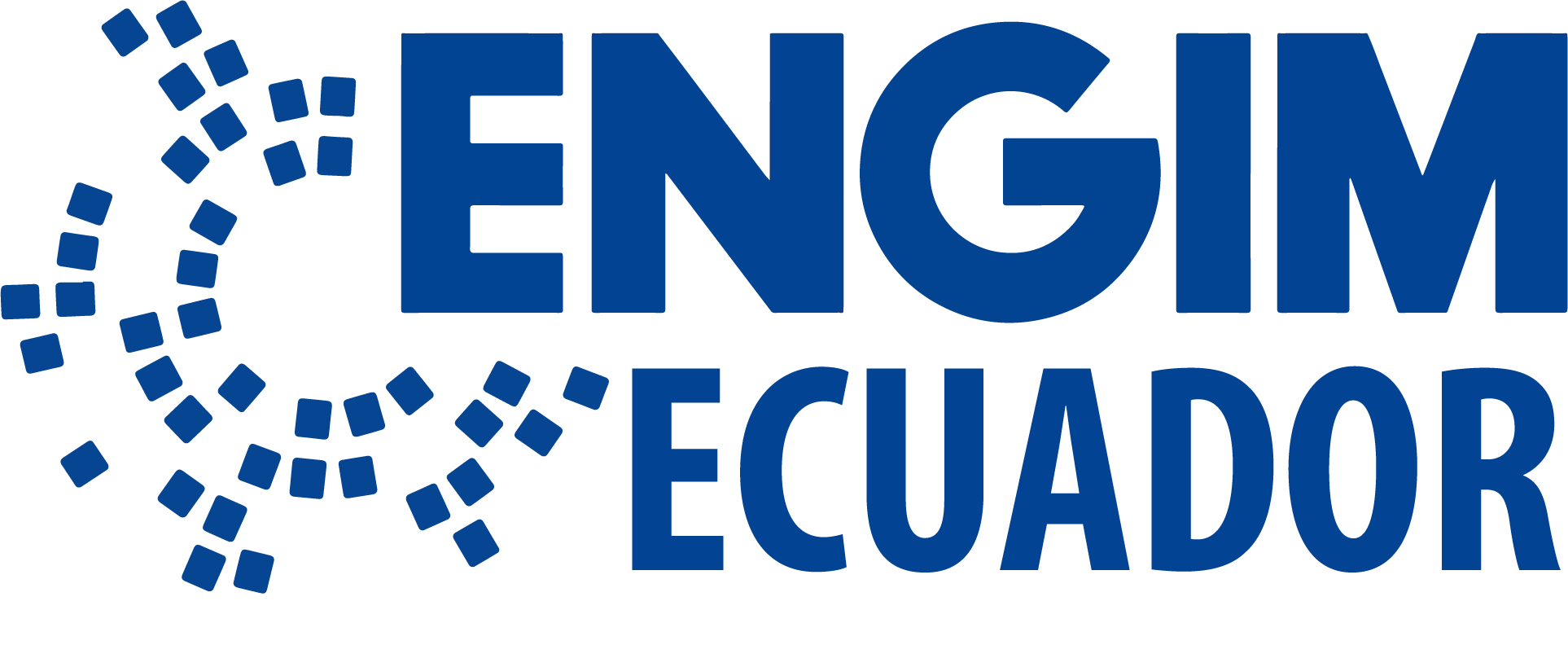di Diana Vicari. Nel 1966 da Thiene, in provincia di Vicenza, ha inizio il suo viaggio verso l’Ecuador. Un viaggio che, padre Mario Perin della congregazione dei Giuseppini del Murialdo, ha deciso d’intraprendere a 31 anni con un obiettivo ben preciso: aiutare e supportare i giovani ecuadoriani nella loro crescita. Una missione che oggi, all’età di 86 anni, padre Mario continua a portare avanti con grinta e motivazione.
Come mai la scelta dell’Ecuador?
Insegnavo da due anni in una scuola primaria a Thiene, in provincia di Vicenza. Dentro di me però maturava l’idea d’intraprendere un’esperienza
in altre parti del mondo. Così ho scritto a colui che un tempo era il padre che si trovava a capo della Congregazione per chiedergli se il mio desiderio poteva essere esaudito. Lui approvò la mia richiesta dicendomi: “Penso che tu debba andare in Ecuador”.
Io ne rimasi stupito, non sapevo nemmeno dove si trovasse l’Ecuador. Non conoscevo nulla dell’America Latina, né la lingua, né i costumi, ciò nonostante decisi di dare inizio a questo viaggio. Era il 1966 quando mi imbarcai da Napoli in una nave insieme a padre Cesare Ricci.
La prima tappa fu Barcellona, poi attraversammo lo stretto di Gibilterra, fu poi la volta del Venezuela e del meraviglioso stretto di Panama.
Deve essere stato un viaggio emozionante…
Eravamo cinquecento passeggeri, ogni giorno era programmata una qualche attività, tra concerti e balli. C’era anche una piccola cappella dove noi sacerdoti potevamo celebrare la messa.
Per me quel viaggio fu come una lunga gita in quella che sembrava una piccola città che si muoveva sull’oceano. Arrivato in Ecuador a Guayaquil, mi colpì molto la povertà di questa città. La mia seconda tappa è stata Quito, dove mi sono soffermato una ventina di giorni per recuperare le forze. Poi mi sono diretto verso Tena, dove ad attendermi c’era Monsignore Massimiliano Spiller, un missionario che amava tanto l’Ecuador e credeva nella missione.
Com’è stato il primo impatto con la cultura del luogo?
Quando sono arrivato qui ero molto giovane, avevo da poco finito gli studi a Roma e lo sforzo più grande fu proprio quello di comprendere la gente, i loro usi e costumi.
A colpirmi fu la tranquillità del popolo ecuadoriano e il loro stile di vita lento e tranquillo. In Italia io ero abituato a ritmi frenetici ad andare sempre di corsa, dietro agli orari, qui invece la gente aveva uno stile di vita diverso. Faceva ogni giorno quello che poteva.
Di cosa si è occupato qui a Tena?
Durante il primo anno, dato che ancora non conoscevo bene la lingua, le mie giornate erano dedicate ad assistere i bambini orfani dell’internato. Li accompagnavo a scuola, poi nel pomeriggio li aiutavo a fare i compiti e li portavo al fiume per fare il bagno. L’anno successivo Monsignor Spiller mi disse: “Ho bisogno che tu vada a Cotundo”, una piccola cittadina poco distante da qui. E così io feci. In quel luogo cominciai la vera missione come parroco e imparai l’idioma kichwa.
Cosa ha apprezzato della cultura dell’Ecuador?
Mi ha sempre colpito il rapporto dei nativi con la religione e la spiritualità. Ad esempio, il sole è da loro chiamato Ñucanchi Inti, ossia colui che da la forza e il calore, la terra invece, Ñucanchi mama, nostra madre, colei che ci mette al mondo e che ci fornisce gli alimenti necessari per la vita. La terra che un giorno, quando moriremo, ci riaccoglierà nuovamente con lei.